Il carcere di Santo Stefano fa i miracoli: fa diventare garantisti tutti
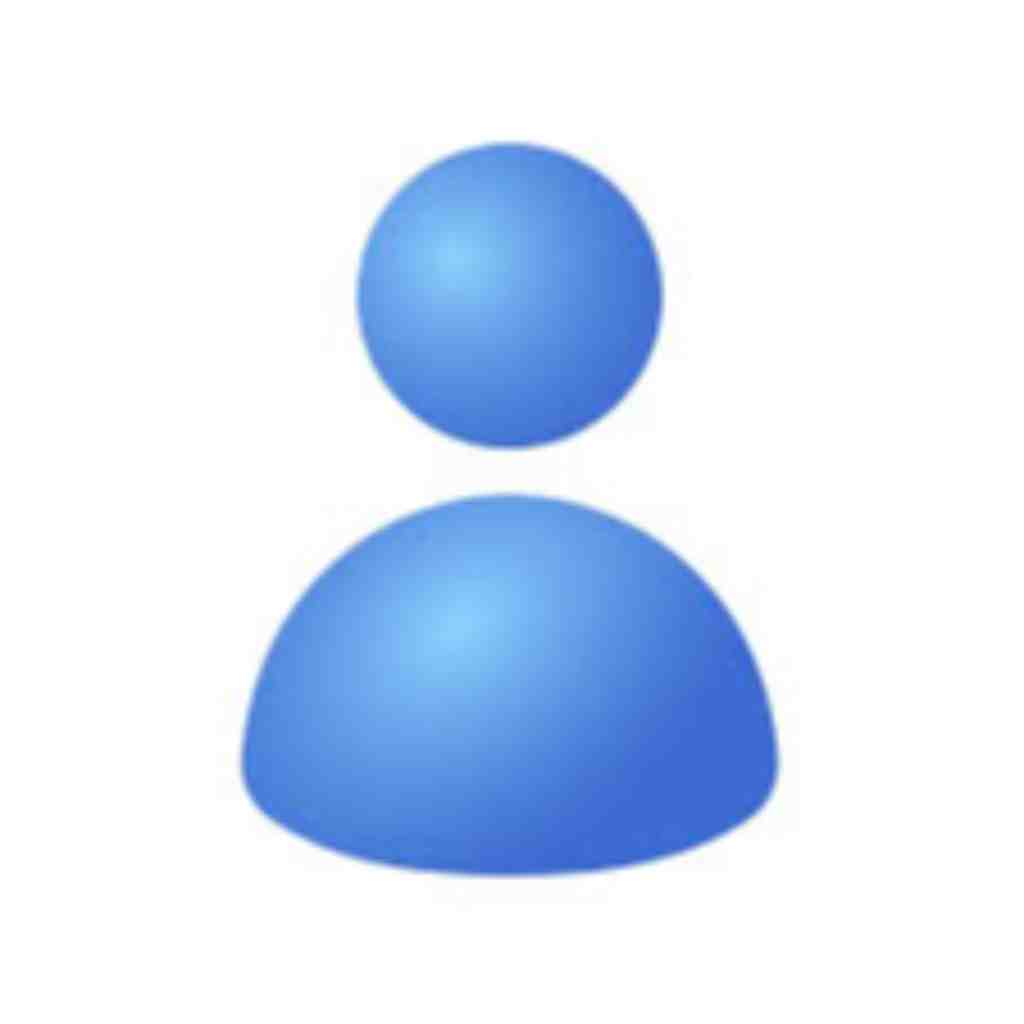

La pianta del Santo Stefano è quella del Panopticon di Jeremy Bentham: al centro la torre di controllo (sacro e temporale: c’era la cappella e c’era pure la cabina delle guardie) e intorno le celle, di modo che ai prigionieri fosse chiaro d’essere sorvegliati continuamente. Ciascuna cella era dotata di finestre a bocca di lupo che impedivano ai detenuti di vedere il mare (tuttavia ne sentivano l’odore e il rumore suo e di chi lo abitava o attraversava: è scritto nelle memorie di moltissimi internati). All’SS si scontavano gli ergastoli. Il fine pena mai. La ragione per cui andare a visitare quelle gabbie per uomini sbagliati la spiega a un certo punto uno degli intervistati: “Questo posto è l’espressione massima del fine pena mai, di cosa un uomo può fare a un altro uomo”. Un carcere dismesso è il solo posto al mondo in cui c’è speranza che persino a Salvini diventi chiaro come e perché, stante il sacrosanto principio di responsabilità personale, quando un membro di una comunità finisce in galera, quella comunità ha fallito.
Un ferito a morte ha il diritto di levare per sempre il cielo e il mare al suo feritore? Non è importante rispondere (perché è impossibile rispondere), ma domandarselo sì. Sempre. Dovremmo domandarcelo continuamente.
Viene raccontato nel documentario che quando Sandro Pertini finì a Santo Stefano (pena: 10 anni e nove mesi; fu avvistato a Pisa da un avvocato fascista di Savona che era lì per andare allo stadio ma non si lasciò sfuggire l’occasione di denunciare l’eversivo comunista), scrisse: “Al pensiero che sarei stato nello stesso carcere dove era stato rinchiuso Luigi Settembrini, mi sentii orgoglioso”. All’SS finirono patrioti, prigionieri politici, carbonari, giacobini, antifascisti: due secoli e mezzo di opposizione e rivoluzione fatte a spese della propria pelle. I trenta minuti di questo documentario bastano a capire che là dentro, per tutto quel tempo, uomini che hanno sbagliato anche solo la parte in cui stare, hanno avuto l’immensa, disgraziata fortuna di conoscere l’uguaglianza. Perché così ha detto De Andrè: il carcere è una realtà non individualista, il massimo dell’essere uguali.

